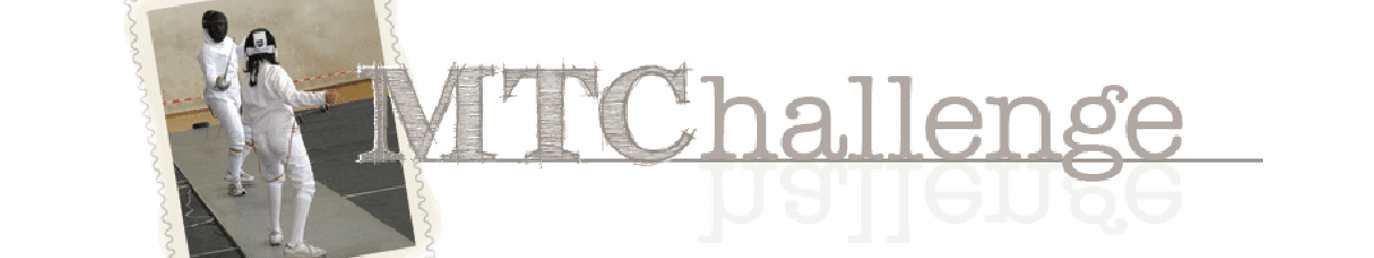La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo é una iniziativa promossa dalle Ambasciate, i Consolati, gli Istituti di Cultura italiani e gli uffici delle Camere di Commercio Europee all’estero, allo scopo di promuovere i prodotti e le tradizioni della cucina del nostro Paese nel mondo.
Da otto anni, nella terza settimana di Novembre, tutti i Paesi che ospitano le Ambasciate italiane si animano con una serie di eventi volti a far conoscere la nostra cucina attraverso incontri, conferenze, corsi, cene e via dicendo, in una rassegna variegata ispirata ogni anno a temi diversi.
Quest’anno anche #Cook_My_Books parteciperà a uno di questi eventi e lo farà con una piccola pubblicazione tutta dedicata alle ricette con la Rosa.
Il tema dell’VIII edizione é infatti “A tavola con la cucina Italiana: il benessere con gusto” e questo si sposa benissimo con uno dei miei tanti pallini, la storia della Rosa nella gastronomia.
Da Genovese, infatti, sono sempre stata orgogliosissima del fatto che la mia città e i suoi dintorni (il Genovesato, appunto) siano stati l’unico luogo d’Italia a mantenere questa tradizione, oggi simboleggiata dallo Sciroppo di Rose, ininterrottamente, dal tempo delle Crociate in poi.
Una storia bellissima che si intreccia anche con il ruolo di Genova nel commercio dello zucchero, con la sua storia di confettieri e canditori e che trova il suo omologo europeo in Bulgaria, Paese che ha fatto della Rosa il suo simbolo.
Grazie all’ICE di Sofia e alla sua Presidente, Chiara Petró, sono stata invitata a parlarne proprio in questa settimana, in una serie di eventi in cui la storia della Rosa nella gastronomia diventerà protagonista: grazie alle signore di #Cook_My_Books, infatti, le mie chiacchierate saranno corredate da una pubblicazione (curata dalla Farnesina) dedicata alle ricette con la Rosa preparate da loro.
Da qui, la decisione di pubblicarle anche per voi, in attesa – chissà- di racchiuderle in una monografia tutta nostra.
MOUSSE DI PROSCIUTTO ALLA ROSA

Anche se la Rosa è un fiore molto presente nella cultura occidentale, tanto da aver assunto su di sé significati simbolici importanti, la sua presenza sulle tavole europee é poco documentata, ad eccezione di isolate aree geografiche: fra queste, spiccano la Bulgaria, con la celeberrima Valle delle Rose a concentrare una tradizione secolare, dal giardino alla cucina, e Genova e il Genovesato, nella fattispecie la Valle Scrivia dove da tempo immemorabile le rose vengono preservate, sotto forma di canditi e, soprattutto, di Sciroppi
Lo Sciroppo di Rosa della Valle Scrivia oggi é diventato Presidio Slow Food, la produzione, un tempo sempre più relegata alle cucine delle nonne e a quelle dei conventi, ha ripreso vigore nei laboratori delle confetterie, generando pubblicazioni e approfondimenti (su tutti, la monografia di Sergio Rossi dedicata proprio allo Sciroppo di Rose, per Sagep e gli articoli del @calendarioitalianodelcibo)
In questa settimana, affronteremo l’argomento da più parti, ma il mio interesse nasce principalmente da una domanda: vale a dire perché l’Oriente ha preservato l’utilizzo della Rosa in cucina e l’Occidente, per contro, lo abbia bruscamente interrotto dopo la caduta dell’Impero Romano, per poi riprenderlo prevalentemente per i prodotti dolciari
Gli anni trascorsi a Singapore, dove la presenza della Rosa era anche al centro di un dibattito fra tradizione e innovazione, con i giovani chef che proponevano rielaborazioni di piatti antichi, suddivisi in tutte le portate, hanno ulteriormente acuito la mia curiosità, senza trovare risposte.
Ogni volta che si parla di cibo, si schiudono infinite porte sui sentieri della Storia, dell’Arte, dell’Antropologia, della Religione, della Mitologia, in un viaggio senza fine dove la Rosa non fa eccezione
Benvenuti a questo piccolo excursus illuminato dalle ricette delle signore di Cook My Books, seguite il loro profilo Instagram, sarà più facile non perderle di vista
🌹 MOUSSE DI PROSCIUTTO ALLA ROSA di @tartetatina
RICETTA QUI
QUAGLIE E ROSE

Ci fu un giorno, in un tempo lontano, così lontano da non essere ancora tempo, in cui Visnu chiese a Brahama quale fosse il fiore più bello.
“Il Loto”, rispose quest’ultimo, memore di essere nato proprio da questo fiore.
“Ti sbagli”, replicò Visnu.
“Il fiore piú bello di tutti é la Rosa”.
Sul momento, Brahama restò senza parole: che cosa mai era quel fiore di cui Visnu blaterava?
In mancanza di Google, chiese umilmente al suo amico (e compagno di Trinità e padre, perché non c’é Pantheon che sfugga alla regola sovrana delle relazioni complicate) di mostrargli questo fiore e, nn appena lo vide, non solo cambiò idea immediatamente, ma fece spuntare dal terreno 108 cespugli con 1008 rose ciascuno, per assicurarne la loro presenza all’umanità.
Da uno di questi nacque addirittura la sposa di Visnu e potrei proseguire per ore, se non fosse che perderemmo il significato principale di questo mito che non é il resoconto di una discussione fra gli dei e neppure l’archetipo di un manuale di giardinaggio, bensì la conferma del ruolo centrale che la Rosa ebbe nella cultura indiana, sin dalle sue origini.
La ragione va ricercata, molto banalmente, nelle sue proprietà terapeutiche.
La Rosa, infatti, fa bene: é ricca di vitamina C, ha proprietà decongestionanti, agevola la digestione, riduce gli attacchi di ansia, come ben sanno tutti gli Erboristi, oggi e come avevano intuito i padri della Medicina Ajurvedica allora, tanto da assegnare alla Rosa un posto predominante, come fiore che presiede al femminile, quindi a ciò che dà vita.
Da qui a venire utilizzata nel campo dell’alimentazione, il passo é breve: perché nelle culture orientali, l’annosa domanda del “cosa preparo per cena?” é sempre ispirata ad un solo principio: si mangia quello che ci fa stare bene, per questo la tradizione gastronomica della Rosa in cucina si perde nella notte dei tempi e prosegue ancora oggi, modulandosi anche sulle nuove istanze della contemporaneità: perché la Rosa fa bene e tanto basta.
🌹 QUAGLIE E ROSE di @giuliffa
RICETTA QUI
SALMONE AL FORNO CON KETCHUP ALLA ROSA

Per capire come mai, invece, l’Occidente interrompe bruscamente questa usanza, bisogna soffermarsi brevemente sui banchetti della Roma imperiale.
La Rosa é una dei protagonisti, sotto forma di bevanda (il celeberrimo vino rosato di cui pare tutti andassero pazzi), di dolce (la Patina de Rosis, antesignana dei nostri budini) e come aromatizzatore trasversale, in tutte le portate.
Profumare di rose il cibo era infatti un segno di raffinatezza tanto che, nella gara ossessiva a fare sfoggio di ricchezze che fu uno sei sintomi piú volgari di quest’epoca malata, si verificarono anche episodi tragici: su tutti, quello incorso nel palazzo di Elogabalo dove venne istallato un finto soffitto carico di petali di rose, che si sarebbe dovuto aprire a metà del pranzo, con un effetto scenografico che, nella realtà, si tradusse in tragedia, visto che gli ospiti vennero letteralmente sommersi da una frana di petali e molti di loro morirono soffocati.
Da qui, si può capire come, dopo la caduta dell’Impero Romano e il nuovo ruolo della Chiesa come baluardo della vecchia cultura contro l’avanzare del nuovo, la Rosa avesse assunto un significato negativo, essendo associata alla società dissoluta di quel tempo e per questo venne bandita da tutto, anche dai giardini.
E qui, abbiamo il punto nodale della questione, lo scarto fra Oriente e Occidente che emerge in maniera nettissima, quando si parla di cibo: a Est, si valuta la sostanza (se fa bene, é buono).
A Ovest, l’apparenza, o meglio: il significato culturale che un cibo assume, nel corso dei secoli.
Non a caso, nei banchetti medievali non si mangiava per nutrirsi, ma per essere visti, per confermare il proprio ruolo di potere, la propria forza, il proprio vigore, in una forma mentis che dura tuttora.
Quindi, della Rosa non si valutano le proprietà terapeutiche, ma la simbologia: e tanto basta, per metterla al bando (segue)
🌹 SALMONE AL FORNO CON KETCHUP ALLA ROSA di @murzillosaporito
RICETTA QUI
AMARETTI ALLA ROSA
di Nicol Pini

Tuttavia, non passò molto tempo che la Rosa finì per conquistare gli uomini di chiesa: si tornò a coltivarla, nei chiostri e nei giardini e, soprattutto, si iniziò a preservarla nelle cucine dei conventi, sotto forma di medicamento e di aromatizzatore.
Una nuova spinta venne dalle Crociate e dalla scoperta della canditura che ai Genovesi fece balenare la prospettiva di un nuovo, lucroso affare con il commercio dello zucchero, oltre che dagli utilizzi quasi miracolosi dell’acqua di rose, affidati a racconti in bilico fra il fascinans e il tremendum, come quello che vide il feroce Saladino purificare Gerusalemme dalla strage degli infedeli versando litri di acqua di rose, portati sul dorso di 500 cammelli.
Non a caso, fu l’acqua di rose, usata a profusione nelle varie pestilenze, a dettare le regole del nuovo utilizzo di questo fiore, non tanto in cucina, quanto in farmacia.
La Rosa, di nuovo, tornò ad essere associata alle terapie e al benessere e, di nuovo, questo costituì un ostacolo per la sua diffusione sulle tavole.
Le medicine non si mangiano, insomma e anche se nella gastronomia italiana abbiamo ricette tradizionali a base di rose, queste sono tutte confinate nei liquori (l’Alchermes fiorentino e il Rosolio siciliano, su tutti) e nella confetteria.
Non é un caso che anche nella mia infanzia lo sciroppo di rose, che pure faceva parte dell’arredamento di casa, assieme al mortaio sulla credenza e al basilico sul davanzale, veniva servito con parsimonia, sempre in occasione o di qualche visita o di qualche malanno.
Il motivo non é solo da ricercarsi nel laborioso processo di produzione (si parte dai petali e ce ne vogliono tanti… e ci si impiega come minimo due giorni), quanto anche in questa posizione al limite, fra bevanda dissetante e medicamento che faceva sì che le nostre nonne lo ritenessero una sorta di panacea universale, per curare il raffreddore, per “mettere a posto lo stomaco”, per riprendersi dalla debolezza (segue)
🌹 AMARETTI ALLA ROSA di @colcavolo_pt
RICETTA QUI
TIRAMISÚ ALLA ROSA

Come avrete intuito, l’argomento é tanto affascinante quanto infinito: vorrei poter andare ancora avanti, ma il calendario mi impone di interrompermi qui, non prima di aver dato spazio a quel piccolo angolo di paradiso che sono i roseti della Valle Scrivia dove la rosa damascena proveniente dalla Turchia, si coltiva almeno da due secoli.
Qui ha preso forma, nel 2000, l’Associazione Rose della Valle Scrivia, a tutela dei prodotti gastronomici che nascono dalla conservazione di questa particolare specie e che hanno nello sciroppo di Rose il suo rappresentante piú famoso.
Al Calendario dei Cibo Italiano abbiamo dato ampio spazio a questa realtà, il cui impegno assiduo ed attento ha permesso lo sviluppo di un disciplinare per tutelare la vera ricetta dello sciroppo di rose (oggi presidio Slow Food), oltre all’organizzazione della Festa delle Rose, a giugno, che coinvolge i produttori e i ristoratori della zona. Le rose piú utilizzate sono quelle che noi chiamiamo, banalmente, “da sciroppo”, ossia la Rugosa e la Centifolia Muscosa, oltre alla Damascena, che nel corso dei secoli si sono talmente adattate all’ambiente da crescere in modo spontaneo e copioso.
Fra maggio e giugno la Valle Scrivia pullula anche di visitatori e turisti che approfittano di questa manifestazione anche per visitare alcuni giardini e, naturalmente, per fare provvista di miele alla rosa, zucchero rosato, birra alla rosa e, naturalmente, lo sciroppo, da sempre il souvenir più tipico e più profumato.
🌹 TIRAMISÚ ALLA ROSA di @sofficiblog
RICETTA QUI
ROSE DI MELA ALLA ROSA

RICETTA QUI
TIRAMISU’ ALLA ROSA CON COULIS DI LAMPONI
di Susy May

RICETTA QUI